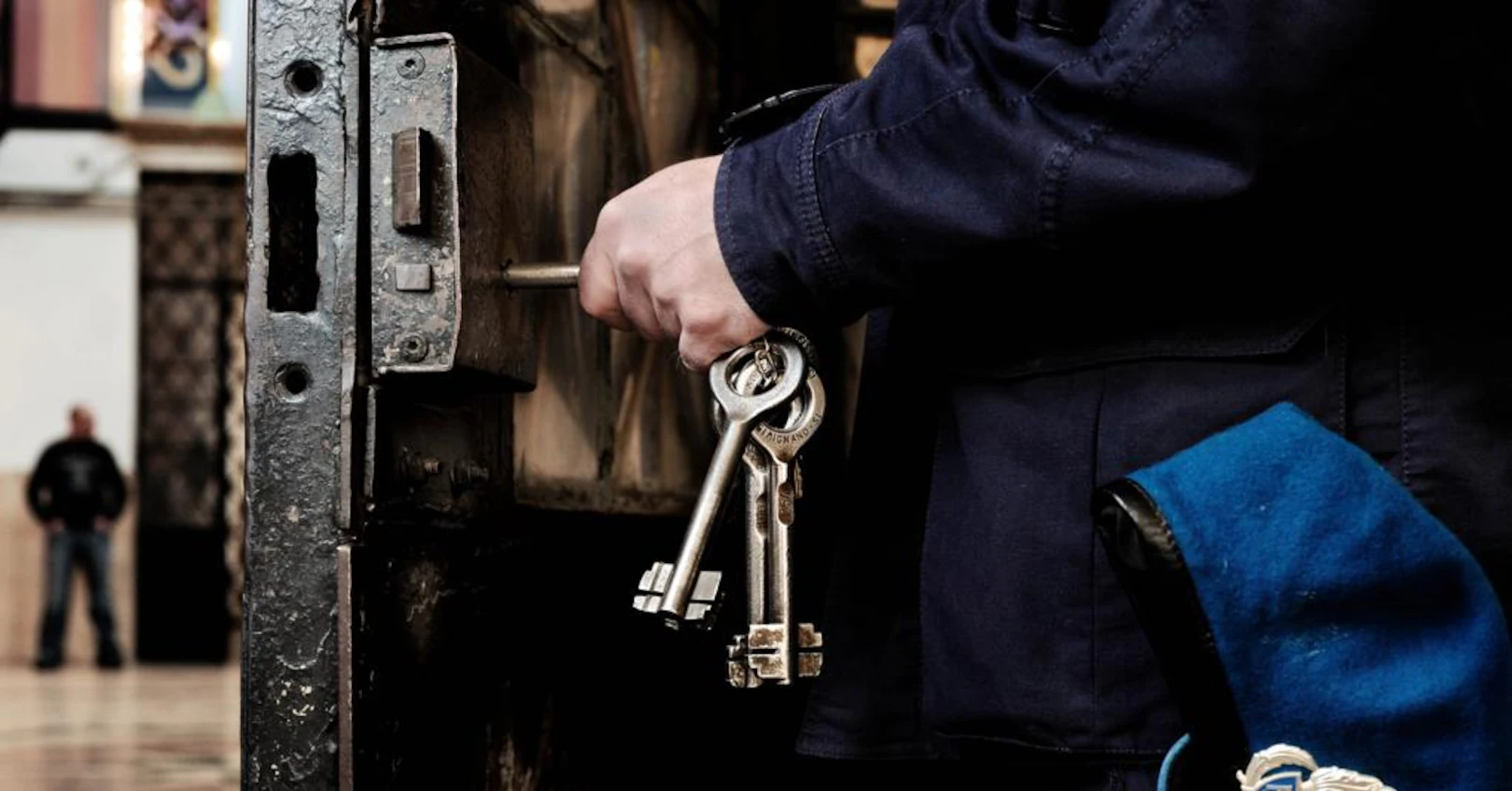ISPPREF “Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale e Familiare”
Corso Specialistico
di
Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense
VII ediz. A.A. 2010-2011
TESI
L’errore giudiziario e l’ingiusta detenzione: la libertà negata
Relatore
Dott. Marco Luongo
Corsista
Dott.ssa Felicita Mastrototaro
Alla mia famiglia e a Lorenzo.
INDICE
Introduzione
CAPITOLO I
La riparazione dell’ingiusta detenzione e dell’errore giudiziario
Il danno non patrimoniale causato dall’ingiusta detenzione e dall’errore giudiziario
Legge Pinto e danno da irragionevole durata del processo
Il ruolo della memoria nel processo penale:
la testimonianza oculare
CAPITOLO II
Il caso di Enzo Tortora
Il ritorno di Tortora e la sua malattia
CAPITOLO III
La tutela delle vittime di malagiustizia: Associazione “Art. 643”
Storie di vita
Le conseguenze di una giustizia ingiusta
Conclusioni
Bibliografia
Ringraziamenti
INTRODUZIONE
Era una sera come tante e cercavo in tv un bel film da guardare. Nulla attirava la mia attenzione fino al momento in cui su Rai1 apparve la scritta di un film “L’uomo sbagliato”. La curiosità mi prese e decisi di guardarlo. L’uomo sbagliato era Daniele Barillà, che è stato protagonista di un clamoroso caso di errore giudiziario per il quale ha scontato sette anni di carcere e affrontato tre gradi di giudizio prima che venisse riconosciuta la sua innocenza. La sua storia mi aveva molto turbato e fece nascere in me la voglia e l’interesse di approfondire un argomento così delicato come l’errore giudiziario e l’ingiusta detenzione.
Nel primo capitolo spiegherò, dal punto di vista giuridico, l’errore giudiziario e l’ingiusta detenzione facendo riferimento alla lesione del danno esistenziale che ne consegue; affronterò il problema delle lungaggini processuali e dell’attendibilità della testimonianza oculare.
Nel secondo capitolo parlerò del caso giudiziario di Enzo Tortora, noto presentatore degli anni ’70, il quale fu vittima sia di un modo sbagliato di amministrare la giustizia sia di un linciaggio mediatico senza precedenti.
Nel terzo capitolo saranno riportate le testimonianze di quattro vittime della giustizia con le quali ho avuto modo di parlare grazie all’intermediazione dell’ avvocato Gabriele Magno, presidente dell’associazione nazionale vittime errori giudiziari “Articolo 643”, che ho personalmente incontrato. Spanò Francesco, Columbu Maria , Gentile Claudio e Bonifacio Fabio sono i protagonisti di storie al limite della realtà e il confronto avuto con loro mi ha permesso di venir a conoscenza non solo di informazioni riguardanti la loro vicenda giudiziaria ma anche di capire i risvolti psicologici e le ricadute sociali.
CAPITOLO I
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, rappresenta un documento storico importante, prodotto come conseguenza delle atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale
Essa dichiara, universalmente, i diritti che spettano all’uomo e, nei trenta articoli di cui si compone, sono sanciti i diritti individuali, civili, politici, sociali, culturali di ogni persona.
Si proclama il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza individuale, ad un trattamento di uguaglianza di fronte alla legge, ad un processo parziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di fede, pensiero, movimento, alla libertà di opinione, associazione ed espressione. Si sancisce il diritto ad avere una nazionalità, a partecipare al governo del proprio paese, a fruire di tempo libero, a lavorare e a ricevere un giusto compenso per il lavoro svolto. Infine, secondo i suoi dettami, si stabilisce che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, e nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.
Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione nella propria Costituzione, proprio perché tali principi rappresentavano un appello rivolto sia al singolo individuo che ad ogni organizzazione sociale per promuovere e garantire il rispetto per le libertà e per i diritti.
La Dichiarazione, quindi, pur non essendo un documento giuridico propriamente vincolante, fu il primo punto di partenza di un nuovo diritto internazionale.
La tutela dell’uomo, infatti, è sempre stata l’obiettivo principale di un’evoluzione che ha trovato concretezza nelle successive conquiste, tanto che il 4 Novembre del 1950 fu firmata a Roma la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali” (C.E.D.U.). Entrata in vigore il 3 settembre 1953 tra i primi dieci stati che la ratificarono, essa fu ratificata in Italia solo il 26 Ottobre 1955, con la legge n. 848.
La Convenzione dei diritti dell’uomo si ispira ai principi e agli ideali sanciti nella Magna Charta del 1215, nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1976, nella Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1978 e nella Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948.
Essa, però, non si è limitata a ribadire gli ultimi principi enunciati nella Dichiarazione Universale, bensì ne ha ampliato i contenuti, permettendo, in questo modo, una tutela giurisdizionale non prevista prima.
Garantendo diritti politici e civili con l’enunciazione di qualche diritto economico, sociale e culturale, gli Stati Europei presero coscienza del fatto che l’osservanza dei diritti umani e il rispetto delle libertà fondamentali fossero indispensabili allo sviluppo e al progresso della società, rappresentando la base della “giustizia” e della pace nel mondo.
La Convenzione consta di 59 articoli ed è suddivisa in due titoli: titolo I “dei diritti e libertà” (dall’art. 2 all’art. 18), in cui sono elencati i diritti e le libertà fondamentali che gli Stati si impegnano a riconoscere e garantire ad ogni uomo; titolo II “ Corte Europea dei diritti dell’uomo” (dall’art 19 all’art. 59) dedicato alle attività della Corte Europea e alle modalità di ricorso alla stessa.
La mia attenzione sarà rivolta, principalmente, ad un articolo fondamentale della Convenzione, ovvero l’articolo 5, il quale recita:
“Ogni persona ha diritto alla libertà e sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
Se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
Se è in regolare stato di arresto o detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
Se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
Se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
Se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane e vagabondo;
Se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
Ogni persona, arrestata o detenuta, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparazione della persona all’udienza.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
Ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad un equa riparazione.
In merito al comma 5, risulta palese come la clausola in esso contenuta risponda all’esigenza di assicurare la riparazione ogni qual volta la restrizione della libertà personale risulti disposta contro legge.
La riparazione dell’errore giudiziario e dell’ingiusta detenzione, quindi, sono differenti aspetti di un unico principio di civiltà giuridica, in base al quale lo Stato è tenuto ad assicurare un indennizzo a chi sia stato leso, nei propri diritti fondamentali, nel corso di un procedimento penale.
L’istituto dell’ingiusta detenzione ha l’obiettivo di riparare i danni patiti dal soggetto per l’applicazione di una misura cautelare illegittima; l’istituto dell’errore giudiziario, invece, tende a riparare l’infamia subita da chi, pur innocente, abbia subito una condanna definitiva per un reato. Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e, perciò, prima dell’eventuale condanna, mentre nel secondo caso si prevede una condanna a cui sia stata data esecuzione ed un successivo giudizio di revisione instaurato (a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna) in base a nuove prove.
La riparazione pecuniaria dell’ingiusta detenzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal nuovo codice di procedura penale approvato nel 1988, ed è regolamentata dagli articoli 314 e 315 dello stesso.
L’inserimento di tale istituto rappresenta il riconoscimento del principio di civiltà giuridica e di attuazione dei valori propri di un ordinamento democratico, in virtù del quale chiunque sia stato privato della libertà personale ingiustamente, ha diritto ad un equo indennizzo dallo Stato per i danni materiali e specialmente morali che il soggetto subisce.
Un vero e proprio diritto soggettivo che veniva riconosciuto solo allora, nonostante la dottrina ne avesse già segnalato il grande vuoto normativo esistente prima della sua promulgazione; evento strano in un sistema giuridico, il nostro, in cui la libertà personale è considerata un diritto primario ed inviolabile.
L’articolo 314 c.p.p disciplina due diverse fattispecie di ingiusta detenzione, rispettivamente previste dal comma 1 e dal comma 2.
Il comma 1 disciplina l’ingiustizia sostanziale che ricorre quando vi è proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Tenendo presente che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.
Il comma 2 dell’articolo 314, invece, prevede l’ingiustizia formale che ricorre quando la custodia cautelare è applicata illegalmente e, quindi, senza che siano presenti le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del c.p.p., a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna.
E’ opportuno soffermarsi, a questo punto, sul libro IV del codice di procedura penale che, in una serie di articoli, e precisamente dall’art. 273 e seguenti, disciplina le misure cautelari.
Esse limitano la libertà della persona e possono essere disposte dal giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che durante la fase processuale. Le misure cautelari personali richiedono per la loro applicazione sia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p) che delle esigenze cautelari (art 274 c.p.p). Per esigenze cautelari si intende il rischio di inquinamento delle prove; il concreto pericolo di fuga da parte dell’imputato, sempre che il giudice ritenga che possa essere scontata una pena superiore a 2 anni di reclusione; il rischio di reiterazione del reato, per cui sussiste il concreto pericolo che l’indagato possa commettere ulteriori delitti con armi o altri mezzi, o delitti di criminalità organizzata o il medesimo delitto per il quale si procede (in quest’ultimo caso può essere disposta la custodia cautelare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è uguale o superiore a 4 anni).
L’articolo 280, invece, sancisce le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, le quali possono essere applicate per i delitti punibili con l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 3 anni, per delitti consumati o tentati per i quali è prevista una pena non inferiore a 4 anni.
Nel nostro codice, quindi, sono indicati chiaramente i casi in cui le misure cautelari possono essere applicate, tanto che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel sostenere che il cittadino che sia stato ingiustamente detenuto, abbia il diritto di ricevere una riparazione per il danno subito.
L’obbligo dello Stato di pagare una somma di denaro, però, è subordinato al riconoscimento della “validità” della domanda di richiesta di un’equa riparazione, in quanto il soggetto godrà di tale diritto soggettivo solo se sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere. Al contrario, non avrà diritto ad essere indennizzato per l’ingiusta detenzione colui che abbia, in qualche modo, contribuito a determinarla con un suo comportamento doloso o gravemente colposo.
Successivamente, sono state apportate rilevanti novità in materia di riparazione, specialmente dalla legge del 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”, il cui articolo 15 ha modificato l’art. 315 del nostro codice di procedura penale.
Il primo cambiamento riguarda l’aumento del limite massimo di risarcimento per aver subito un’ingiusta detenzione, così passando da cento milioni di lire a un miliardo (oggi 516.456,90 euro). Il secondo cambiamento concerne la presentazione della domanda di riparazione, da proporsi entro due anni, e non più come in passato 18 mesi, altrimenti essa risulta inammissibile; sulla richiesta decide la Corte d’Appello con un procedimento in camera di Consiglio.
Per la quantificazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto della durata della custodia cautelare ingiusta, della tipologia della misura applicata, delle conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali derivati proprio dalla privazione della libertà. I giudici, insomma, valutano di volta in volta le circostanze del caso concreto.
Diversi sono i casi, in Italia, di ingiusta detenzione e di errori giudiziari: nonostante il giudice possa possedere mezzi affidati per conoscere la verità, niente può garantire in senso assoluto dall’errore giudiziario. L’ordinamento italiano, cosciente del fatto che tale fenomeno possa verificarsi, ha creato forme di tutela per l’individuo tese a riparare o mitigarne gli effetti negativi subiti.
L’errore giudiziario si verifica quando un soggetto, dopo aver espiato una pena per effetto di una sentenza di condanna, viene riconosciuto innocente in seguito ad un nuovo processo, detto di “revisione” che rappresenta uno strumento di impugnazione straordinario in quanto esperibile, senza limiti di tempo, a favore dei condannati. A differenza dell’ingiusta detenzione, l’istituto dell’errore giudiziario è presente nel nostro ordinamento sin dall’approvazione della Costituzione che all’articolo 24 stabilisce:“ la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
In particolare, l’art. 643 c.p.p., quale fonte di un vero e proprio diritto soggettivo, indica precisi parametri che permettono di determinare il danno causato da un errore giudiziario: la durata della pena espiata e le conseguenze personali e familiari derivati dall’ingiusta condanna.
Come nell’ingiusta detenzione, la riparazione si materializza nel pagamento di una somma di denaro a favore della vittima e i presupposti essenziali per tale riparazione sono sia positivi che negativi: per presupposto positivo s’intende il proscioglimento in sede di revisione; per presupposto negativo s’intende il caso in cui il soggetto, prosciolto in sede di revisione, non deve aver causato, per un suo comportamento doloso o colposo, l’errore giudiziario.
Fondamentale, però, appare la circostanza per cui sia la riparazione da errore giudiziario, che quella per ingiusta detenzione, non abbiano natura risarcitoria, in quanto rappresentano una semplice indennità che si ricollega all’atto dannoso commesso dagli organi dello Stato nell’esercizio della loro attività.
Nel processo penale, infatti, vige il principio del libero convincimento del giudice, il cui giudizio è “sovrano”. Dovendo fare emergere il reale sviluppo dei fatti, egli dovrà giungere ad una perfetta coincidenza tra questo e il giudizio finale, affidandosi, in caso di conflitto tra la realtà reale e quella processuale, a quella processuale. E, dovendo fondare il proprio convincimento sui verbali, le sensazioni personali dei testimoni, i vuoti di memoria, egli potrà arrivare ad un verdetto distante dalla realtà, commettendo un errore giudiziario.
Le statistiche confermano che in carcere vi sono molti innocenti. Infatti, secondo un calcolo compiuto dall’Eurispes, nell’arco degli ultimi cinquant’anni sarebbero 4 milioni le vittime di malagiustizia, un numero che mostra una vera e propria crisi del sistema giudiziario italiano, crisi dovuta anche al “modo” in cui la giustizia italiana punisce i giudici che commettono tali errori.
La legge n. 117 del 1988 stabilisce che il giudice italiano è chiamato a rispondere di un suo errore solo in caso di “dolo o colpa grave”.
Bisognerà provare, quindi, che egli abbia compiuto volontariamente un atto che violi la legge e, qualora si riuscisse a dimostrare ciò, non sarà il giudice a pagare, ma lo Stato italiano. E, poi, non tutti gli errori sono coscienti, se si considera che i giudici sono uomini e possono sbagliare, pur essendo convinti della correttezza del loro operato.
Una riflessione, però, deve accompagnarci: di qualunque natura sia l’errore, esso conduce sempre al medesimo risultato, sì, perché, anche un solo giorno in carcere può cambiare radicalmente la vita di un uomo.
Il danno non patrimoniale causato dall’errore giudiziario e ingiusta detenzione
Nel campo della responsabilità civile, dottrina e giurisprudenza hanno dovuto confrontarsi e discutere riguardo ad un aspetto molto importante, quello dell’analisi del danno non patrimoniale.
Bisogna distinguere, all’interno del danno non patrimoniale,:
Il danno morale, inteso come sofferenza interna del soggetto causata dal reato.
Il danno biologico, visto come lesione all’integrità psico-fisica del soggetto derivante da un evento dannoso.
Il danno esistenziale, inteso come pregiudizio che cambia le abitudini dell’individuo, inducendolo a scelte diverse, perché modificando in negativo la qualità della vita, sia a livello individuale che a livello socio-familiare, si impedisce al soggetto di fare ciò che avrebbe voluto.
Inizialmente il risarcimento del danno si basava, secondo il modello previsto dal codice civile del 1942, sulla bipartizione danno patrimoniale – danno non patrimoniale. Quest’ultimo, disciplinato dall’articolo 2059 c.c., con il combinato disposto dell’articolo 185 c.p., assicurava tutela al solo danno morale soggettivo nei casi previsti dalla legge.
Successivamente questo modello tradizionale ha subito un brusco cambiamento con l’entrata in scena del danno biologico, affermato per la prima volta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 e le pronunce n. 8827/03 e 8828/03 della Corte di Cassazione. La decisione n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi, confermando la riduzione del danno biologico all’area del danno non patrimoniale, lo ha differenziato sia dal danno patrimoniale, inteso come lesioni di natura economica, sia dal danno morale soggettivo.
Tuttavia la categoria del danno non patrimoniale era destinata a subire ulteriori sviluppi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7713 del 7 luglio 2000, riconosceva la risarcibilità del danno esistenziale e con le sentenze n. 6572 e n. 13456 del 2006 definiva, definitivamente, la figura del danno esistenziale come quel pregiudizio di natura non meramente oggettiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Proprio nel campo del risarcimento del danno da errori giudiziari pesa il riferimento al danno esistenziale, quale categoria importante nell’individuazione del torto subito.
Infatti, è necessario assicurare il risarcimento di tutto ciò che il processo si è portato via dell’esistenza di una persona. L’errore giudiziario rappresenta un caso emblematico dello sconvolgimento esistenziale procurato da una detenzione, da una lunga condanna da espiare rivelatesi poi ingiuste, e che hanno come conseguenze: la privazione della libertà personale, l’interruzione dell’attività lavorativa e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento delle abitudini di vita.
Il danno esistenziale non costituisce una componente né del danno biologico, in quanto non prevede nessuna lesione fisica, né del danno morale soggettivo, in quanto quest’ultimo è un danno prettamente di natura psicologica. Esso comprende, invece, le conseguenze di natura psicologica che i cambiamenti, in negativo, della vita quotidiana hanno prodotto nel soggetto.
Si tratta di categorie del tutto distinte e non sovrapponibili, se si considera che, proprio in relazione all’ingiusta detenzione, un soggetto che abbia trascorso un solo giorno in carcere può subire un danno morale, per essere stato scosso dalla negativa esperienza, ma non un danno esistenziale. La vita del soggetto, infatti, dopo poche ore, ritorna alla normalità, pur con un profondo senso di amarezza.
La questione è diversa nel caso in cui un soggetto, dichiarato poi innocente, subisca un processo, una condanna lunga da espiare, una misura cautelare ingiusta: in quel caso, sicuramente, si assiste a un grave danno esistenziale, in quanto per tutto il periodo della detenzione il soggetto ha perso, pian piano, i punti di riferimento della sua vita precedente, perdendo non solo gli affetti, ma tutto ciò che aveva costruito fino a quel momento.
Di conseguenza, non vi è alcun dubbio nel ritenere che entrambe le situazioni, ingiusta detenzione o errore giudiziario, siano idonee a provocare quello sconvolgimento della vita personale ed affettiva che va sotto il nome di danno esistenziale.
Quest’ultimo potrà essere risarcito in virtù di una valutazione che il giudice dovrà compiere caso per caso; infatti, proprio nel caso dell’errore giudiziario e dell’ingiusta detenzione, s’impone al soggetto di indicare tutte le conseguenze personali e familiari derivate dalla privazione della libertà personale e il giudice dovrà tener conto di tutto questo per determinare il quantum dell’indennizzo. Se il soggetto, invece, non indica adeguatamente tali conseguenze, il giudice potrà determinare il danno in relazione a ciò che emerge dagli atti.
Fermo restando che una somma di denaro non potrà mai ripagare pienamente né l’indagato/imputato, né i suoi familiari che hanno subito le innumerevoli e devastanti incidenze negative arrecate da un errore giudiziario o un’ingiusta detenzione.
Legge Pinto e danno da irragionevole durata del processo.
Le origini normative che disciplinano la durata dei processi devono essere ricercate nell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, che detta una serie di diritti processuali volti a garantire una buona amministrazione della giustizia.
Il suddetto articolo riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, stabilendo, così, il diritto ad un equo processo. Ed è proprio la Convenzione che prevede che il tempo della causa si calcola considerando il dies a quo, e, cioè, il momento in cui il procedimento ha inizio e il dies ad quem che determina la fine della procedura. Naturalmente la determinazione di questi due momenti cambia a secondo del tipo di procedimento: ad esempio, per quanto concerne il processo civile il momento iniziale coincide con il primo atto con cui si incardina il giudizio dinnanzi alla giurisdizione competente; per il processo penale, l’inizio coincide con qualsiasi atto a seguito del quale l’indagato sia venuto a conoscenza della accuse a suo carico. Invece, il momento finale del processo, civile o penale che sia, è quello della sentenza definitiva.
Tale disposizione, però, è rimasta per lungo tempo inoperosa nel nostro ordinamento e, proprio per il mancato rispetto dell’articolo 6 della C.E.D.U da parte dell’Italia, il nostro paese è stato imputato più volte a Strasburgo e, successivamente, condannato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Le numerose condanne subite in sede internazionale, costrinsero il legislatore italiano ad introdurre, nella nostra Costituzione, una disposizione che conferisse rango costituzionale al diritto sancito dall’articolo 6. E, così, la legge n. 2 del 23 novembre 1999, modificando l’articolo 111 della Costituzione, sancì il diritto alla ragionevole durata del processo e consacrò principi e garanzie quali parità delle parti, terzietà e imparzialità del giudice e contraddittorio, garantendo così un giusto processo.
La situazione, purtroppo, non cambiò molto in quanto il diritto garantito dall’art. 111 continuava ad essere leso ripetutamente, e ciò anche per l’assenza di una sanzione in caso di violazione dello stesso. Il tema della durata del processo italiano, infatti, è sempre stato tra i più spinosi, proprio a causa della lunghezza dei giudizi che non dovrebbero superare i limiti della ragionevolezza.
La lentezza della giustizia, infatti, rappresenta la negazione della giustizia stessa, in quanto costringe l’individuo a vivere in una situazione di stallo giurisprudenziale che, se prolungata per molto tempo, diventa un qualcosa di inaccettabile in uno Stato di diritto.
Allora, al fine di adeguarsi ai diritti sanciti dalla Corte Europea e per evitare e limitare le ulteriori condanne da parte della Corte di Strasburgo, è stata introdotta nel nostro ordinamento la legge n. 89 del 24 marzo 2001, la c.d. Legge Pinto, la quale sancisce il diritto ad ottenere un equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali a chi è stato coinvolto in un processo, penale, civile, amministrativo etc.. per un periodo considerato troppo lungo.
La legge non stabilisce un limite che, se oltrepassato, dà vita al diritto all’equa riparazione, ma detta i principi in base ai quali si può desumere se il processo abbia o no avuto una durata irragionevole. L’articolo 2, infatti, prevede che “ nell’accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”. Anche se ogni fattispecie deve essere valutata singolarmente e autonomamente, la giurisprudenza, negli anni, ha stabilito che il procedimento in 1° grado debba concludersi entro 3,4 anni; quello di 2° grado in 2 anni e in 1 anno il procedimento in Cassazione. Superati tali limiti, il soggetto che ha rivestito il ruolo di parte processuale nella controversia, ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo pari a circa 1000/1500 euro; tale somma può aumentare o diminuire a seconda dei casi.
Uno degli aspetti più difficili della legge Pinto riguarda l’onere della prova del danno subito a causa dell’irragionevole durata del processo, in quanto la normativa si limita semplicemente ad indicare le due categorie di danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale. Ciò ha provocato, nel diritto interno, diversi orientamenti tra loro contrapposti: alcuni, concordi con la giurisprudenza di Strasburgo -che in tema di danno non patrimoniale accordava l’indennizzo in maniera automatica- teorizzavano l’ingresso nel nostro ordinamento di una figura di danno-evento, ovvero il danno viene indennizzato automaticamente al solo verificarsi della violazione. Altri invece, che rappresentavano la maggioranza, richiedevano al danneggiato la prova del danno patito, non considerando che la dimostrazione in giudizio dei patimenti d’animo subiti a causa delle lungaggini processuali, è molto difficile.
A seguito dei numerosi contrasti giurisprudenziali interni, sono intervenute le 4 “sentenze gemelle” della Cassazione ( n. 1338, 1339, 1340, 1341 del 2004), le quali hanno cercato di adeguare la propria giurisprudenza alle pronunce della Corte Europea.
E’ stato stabilito, infatti, che il danno non patrimoniale è una conseguenza della violazione della durata ragionevole del processo ed è normale che un processo protratto per molto tempo provochi nei soggetti coinvolti patema d’animo, ansia, sofferenza morale, nonché conseguenze di carattere psicologico. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui tali conseguenze, ritenute normali, vanno escluse, e ciò accade, ad esempio, quando il protrarsi del processo risponde ad un interesse della parte, o comunque è volto a dare esiti favorevoli alla parte; in assenza di tali circostanze, il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto al soggetto che nel frattempo ha vissuto con ansia e angoscia il periodo fino al momento della sentenza definitiva.
E, poiché, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo aveva equiparato le persone giuridiche a quelle fisiche, sottolineando che, sebbene le prime non possano subire i patimenti e le angosce di un processo lungo, ciò non vale per i loro amministratori e gestori, ciò viene recepito dal nostro ordinamento. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 13504 del 21 luglio 2004, affronta la questione relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali per la società in caso di irragionevole durata del processo. La Suprema Corte considera le persone giuridiche dotate di una soggettività, anche se transitoria e strumentale, in quanto le situazioni giuridiche a loro imputate sono riferibili a persone fisiche, le quali possono subire dei patemi d’animo da una prolungata e ingiustificata durata del processo.
Quindi, anche le persone giuridiche possono usufruire della legge Pinto, al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Dalla stessa Cassazione, anche per le persone giuridiche, e più in generale per i soggetti collettivi, il danno non patrimoniale è inteso come danno morale soggettivo, quale conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria , della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri.
L’eccessiva durata del processo, quindi, quale fonte di ingiustizia sociale, mette a dura prova la resistenza del cittadino destinato a subire i tempi di una giustizia che sembra non avere mai fine
Il ruolo della memoria nel processo penale: la testimonianza oculare
Attendibile o non attendibile che sia, non c’è dubbio che la testimonianza oculare ha sempre un gran peso. In molti casi di errori giudiziari accade, purtroppo, che quando esiste una persona sospettabile è facile convincersi che il caso sia risolto, specialmente quando la vittima è pronta a puntare il dito accusatore. Ci si domanda, allora, se si può credere “ al di là di ogni ragionevole dubbio, alle parole di un testimone oculare”.
Il fatto è che le nostre prestazioni sono sorprendentemente scadenti anche quando cerchiamo di richiamare alla mente particolari che vediamo e usiamo quotidianamente. Si potrebbe supporre che un testimone oculare, osservando un fatto insolito come un crimine, noti un maggior numero di particolari che ricorda molto bene.
Molti fattori, però, deformano il ricordo del testimone. Alcuni sono ovvi: egli vede il fatto una volta sola e di solito non se lo aspetta; quel che vede dura spesso molto poco; i criminali fanno di solito tutto il possibile per ridurre al minimo le probabilità di essere riconosciuti. Infatti, quando una persona sperimenta uno stress estremo, come nel caso della vittima di un crimine, avrà, secondo la Loftus, psicologa statunitense, una capacità ridotta di percepire e di richiamare i particolari dell’evento: l’attenzione del soggetto viene ristretta e la percezione deformata.
Supponiamo che un uomo e una donna abbiano assistito entrambi a due crimini, uno compiuto con violenza e l’altro senza. Sempre secondo gli studi effettuati dalla Loftus, sembra che entrambi ricorderanno i particolari del crimine senza violenza meglio dei particolari del crimine violento. Inoltre, in un crimine violento a mano armata, ad esempio, la vittima dell’aggressione sarà indotta a concentrare gran parte della sua attenzione sull’arma, e meno sull’aggressore o sui particolari dell’avvenimento; i pochi dati disponibili sembrano, infatti, confermare che la presenza di un’arma distrae l’attenzione della vittima dall’aggressore. Inoltre, la paura tende a restringere l’attenzione su quello che sembra il carattere cruciale della situazione e, quindi, a ridurre l’attendibilità del testimone.
Bisogna ricordare che la memoria è un atto ricreativo che non produce il passato fedelmente, ma lo reinventa. Un fatto è inizialmente immagazzinato all’interno della memoria e conservato in essa per un periodo più o meno lungo, fino a quando non viene recuperato mediante un processo riproduttivo. In particolare, nella fase di immagazzinamento, il cervello effettua un’operazione di “codifica” sia delle informazioni che dei dati dell’esperienza sulla base di precedenti schemi presenti in memoria, sulla base di esperienze e convinzioni, e ciò consente al soggetto di attribuire un significato a ciò che ha visto o sentito.
Non si può negare, poi, l’alto rischio di interferenze in questa fase di codifica, in quanto uno stimolo visivo o uditivo può essere associato ad un concetto che non corrisponde alla realtà; di conseguenza, il soggetto ha un ricordo distorto, sbagliato dell’evento a cui ha assistito.
Le informazioni presenti in memoria, infine, posso essere recuperate direttamente o indirettamente. Nel primo caso, il ricordo insorge in maniera autonoma; nel secondo, occorre uno sforzo ricostruttivo perché la memoria è sollecitata da uno stimolo esterno, e il soggetto è costretto a recuperare i propri ricordi riguardo a determinati fatti.
E’ proprio questo il caso dei testimoni. Gli studi di psicologia giudiziaria hanno mostrato che il processo ricostruttivo della memoria del testimone può essere influenzato dal modo in cui vengono poste le domande.
Riguardo alla suggestionabilità delle risposte, una disposizione importante è l’articolo 499 c.p.p. che detta precise regole: “ nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte” (comma 2), e che “nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte” (comma 3).
Il legislatore, con tale disposizione, ha cercato di porre dei limiti al modo con cui viene formulata la domanda. Ad esempio, una domanda suggestiva potrebbe essere formulata nel seguente modo: “ Può riferire di essere stato presente quando il 23 giugno 2011 si consumava la violenza sessuale?”, una domanda, cioè, fatta quando ancora il testimone non ha riferito dove si trovava in quella data precisa. Per questo è opportuno procedere con un metodo “ad imbuto”, cioè, partendo da domande aperte e solo alla fine dell’interrogatorio procedere con domande più precise.
Proprio la Loftus ha eseguito una serie di esperimenti su questo argomento.
In uno di questi, ai soggetti veniva fatto vedere il filmato di uno scontro fra due autovetture; successivamente veniva loro chiesto “a quale velocità stavano viaggiando le due macchine al momento dello scontro”, mentre in un altro caso, alla parola scontro veniva sostituita la parola “schianto”. Le velocità stimate furono massime quando fu usata la parola schianto e minori quando fu usata la parola scontro. Pertanto, se le relazioni dei testimoni di eventi possono essere modificate, ciò significa che è mutato quel che essi ricordano realmente? o che essi stanno semplicemente modificando ciò che dicono? Non è che stiano semplicemente facendo congetture diverse sotto la spinta di fattori sociali? Dai numerosi studi condotti, pare che ciò che ricordiamo sia un insieme di ciò che abbiamo visto e di ciò che abbiamo successivamente pensato.
Studi sono stati condotti anche sul ricordo di facce. Muriel e Woodhead selezionarono alcuni soggetti a cui sottoporre foto di volti sconosciuti, per poi riproporre altri volti simili, ma appartenenti a persone diverse. Scelsero i soggetti che avevano ottenuto i migliori risultati, e li valutarono anche per altri tipi di materiali, come le riproduzioni di dipinti. Il fine del loro esperimento era quello di esaminare se il migliore livello di prestazione ottenuto da questi soggetti nel riconoscimento di facce trovasse riscontro in una migliore memoria in generale, in tutta la memoria visiva o se essi fossero migliori solo nel ricordo di facce. I soggetti migliori nel riconoscimento di facce si rivelarono migliori anche nel riconoscimento di dipinti, ma non nella memoria verbale. Cio’ fa pensare che nella memoria visiva ci sia qualcosa di diverso rispetto alla memoria verbale. Da quegli esperimenti si scoprì che la memoria per le facce dipende da un sistema particolare presente in una parte speciale del cervello.
La memoria per le facce, ad esempio, può essere indotta facilmente in errore attraverso il camuffamento, tant’è che molti criminali usano questo espediente per non essere riconosciuti.
Molto spesso, infine, per ottenere informazioni su di un ricercato vengono usati dei disegni o delle descrizioni.
E’ chiaro, però, che una descrizione verbale, anche quando è molto precisa, è un modo molto inadatto di comunicare l’aspetto di una persona. La polizia, infatti, ha sempre fatto un grande uso dell’identikit, insieme ai disegni eseguiti da artisti appartenenti alla polizia.
Eppure, ci si domanda quanto siano efficaci questi sistemi nel consentire il riconoscimento di un volto rievocato da un testimone
Un gruppo di psicologi dell’università di Aberdeen in Scozia, cercò di dare una risposta interessandosi alla questione, ma ottenne solo risultati deludenti.
Moltissimi sono gli errori commessi nel valutare la veridicità delle dichiarazione dei testimoni e questo può portare i magistrati a predisporre sentenze ingiuste per non aver, forse, considerato che la memoria non è infallibile e conserva molte insidie. Il risultato? Gente innocente costretta a scontare una condanna che difficilmente dimenticherà.
CAPITOLO II
Il caso di Enzo Tortora
“Io sono innocente. Spero, dal profondo del mio cuore, che lo siate anche voi”. Così Enzo Tortora si rivolse ai magistrati prima di ascoltare la loro sentenza. Quello del noto presentatore infatti rappresenta ancora oggi il caso più eclatante di malagiustizia italiana che lo portò ad una morte prematura ma soprattutto ingiusta, perché le accuse, la lunga detenzione e il processo, prima mediatico e poi nelle aule dei tribunali, gli avevano indebolito l’anima e il corpo. Egli ha pagato con la vita la sua battaglia di onestà e trasparenza.
Ma chi era Enzo Tortora?
Nato a Genova nel 1928, dopo la laurea in giornalismo, iniziò a lavorare con Paolo Villaggio in alcuni spettacoli, finché a soli 23 anni riuscì a conquistare la RAI, la quale gli assegnò la conduzione radiofonica del programma “Campanile d’oro”. Nel 1977 il presentatore genovese assunse la conduzione della trasmissione “Portobello”, un programma televisivo che andava in onda su Rai2, considerato in quel periodo uno dei programmi televisivi più popolari mai trasmessi dalla televisione italiana. La trasmissione si ispirava al celebre mercatino londinese in quanto gli spettatori potevano telefonare per cercare di vendere o barattare oggetti, proprio come un mercatino dell’usato.
Tortora aveva una personalità che sfuggiva a qualsiasi facile cliché; era un uomo molto colto, con un linguaggio raffinato, con un naturale savoir faire e questo lo contraddistingueva scatenandogli contro l’invidia dei suoi colleghi.
Tortora stava vivendo un periodo di strepitoso successo, ricco di soddisfazioni e notorietà, ma in quel periodo in Italia, meraviglioso dal punto di vista televisivo, qualcosa stava cambiando.
Nel 1982 il Parlamento Italiano votò la “legge sui pentiti”, che permetteva possibili riduzioni della pena a chi decideva di collaborare con lo Stato nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Un anno dopo iniziò l’incubo e il calvario del noto presentatore.
Il 17 giugno del 1983 Tortora si trovava in uno dei più lussuosi alberghi di Roma, il Plaza, ed è proprio lì che alle 4 del mattino fu svegliato dai carabinieri di Roma, i quali entrarono nella stanza, spalancarono l’armadio, aprirono la valigia, sequestrarono un agenda telefonica e si portarono via un uomo stralunato che aveva avuto solo il tempo di raccogliere la sua roba e gli effetti personali.
Tortora fu condotto in caserma a Roma dove i carabinieri gli comunicarono la notizia del suo arresto disposto dalla procura di Napoli, senza spiegargli il motivo. Iniziò così un incubo senza precedenti. La mattina seguente tutti gli italiani seguirono in tv le immagini che mostravano il celebre presentatore in manette.
pastedGraphic.pdf
Quel giorno per Tortora sarebbe dovuto essere un giorno di gioia grazie al rinnovo del contratto che lo avrebbe legato per un’altra stagione alla trasmissione “Portobello”; invece venivano trasmesse solo immagini toccanti, quelle di un uomo in manette trattato come un delinquente.
Tortora, incredulo, ripensava a ciò che gli era successo nelle ultime ore, incominciò a non star bene a causa di una crisi ipertensiva che gli provocava un’ alterazione del battito cardiaco. Il suo cardiologo chiese di trasferirlo in un centro di terapia intensiva ma non gli fu concesso. L’ordine era che il presentatore avrebbe dovuto lasciare la caserma dopo l’arrivo di giornalisti, curiosi e fotografi. Infatti solo allora i carabinieri lo fecero salire sulla gazzella che lo portò al carcere di Regina Coeli, precisamente nella cella 16bis. Parcheggiarono la macchina sul lato opposto della strada e Tortora fu travolto da flash, telecamere e insulti “ladro, farabutto, ipocrita”.
Le prime ipotesi d’accusa erano due: la prima vedeva il presentatore coinvolto in uno sgarro di 40 milioni con dei trafficanti di droga, la seconda prevedeva il suo coinvolgimento nell’associazione camorristica di Francis Turatello, detto “faccia d’angelo”, con il quale si diceva che avesse stretti rapporti d’amicizia.
L’ accusa si basava su un’agendina trovata nell’abitazione di un camorrista, dov’ era scritto un nome e un recapito telefonico. In seguito le indagine calligrafiche mostrarono che il nome non era Tortora ma Tortona e il numero telefonico non corrispondeva a quello del presentatore, che purtroppo finì nell’inchiesta contro la Nuova Camorra Organizzata (Nco).
Quel venerdì 17 furono emanati dai Sostituti procuratori di Napoli, Lucio Di Pietro e Felice di Persia, 856 ordini di cattura; di questi solo 640 si tramutarono in rinvii a giudizio dopo che i restanti accusati furono prosciolti in istruttoria, comprendendo fra essi anche 90 casi di omonimia. In Campania la Nuova Camorra Organizzata era stata fondata da Raffaele Cutolo, il quale nel 1971 riunì tutte le famiglie della camorra napoletana per costruire una forte organizzazione che potesse competere con la mafia siciliana, e iniziò a reclutare, nel carcere di Poggio Reale, i collaboratori di fiducia che raggiunsero presto le 5.000 unità.
Con la legge dell’82 molti affiliati alla malavita decisero di collaborare con la giustizia. Questi pentiti, come spiegava Michele Morello, il Giudice del processo d’Appello di Tortora, “sono uomini senza ideologie, senza nulla e senza nulla da perdere”; e proprio perché non avevano nulla da perdere, ma tutto da guadagnare, decisero di apparire nel processo di Tortora accusandolo e facendo il suo nome.
Tra questi Giovanni Pandico, in carcere da 13 anni, che diventò il segretario di Cutolo. Egli fece il nome di Tortora al quarto interrogatorio: in un elenco di malavitosi, lo citava al sessantesimo posto con il titolo di camorrista “ad honorem”. Le perizie psichiatriche descrivono Pandico come “uno schizoide affetto da paranoia, uno psicopatico abnorme, una di quelle persone che a causa della loro anormalità soffrono e fanno soffrire la società”. Pasquale Barra, portavoce di Cutolo, definito il “boia delle carceri”, per la crudeltà con cui uccideva le sue vittime, decise di pentirsi in seguito a uno sgarro subito dallo stesso Cutolo, affermando che l’unico modo che aveva per salvarsi era affidarsi ai giudici. Per 17 interrogatori, nonostante gli fosse stato mostrato l’elenco compilato da Giovanni Pandico, non fece mai il nome di Tortora, finché poi, al diciottesimo, improvvisamente cambiò idea. Gianni Melluso, detto “il bello”, uomo intelligente e calcolatore, fece il nome di Tortora solo 7 mesi dopo l’arresto del presentatore genovese.
Il numero dei pentiti, che fecero il nome di Enzo Tortora arrivò a 19 e le accuse non furono più generiche e piene di contraddizioni ma molto dettagliate e precise. Su Tortora si riversarono accuse su accuse che lo descrivevano come un criminale senza scrupoli, annientando la sua immagine sia di giornalista che di uomo di spettacolo. Intanto anche i giornalisti contribuirono a gettare confusione in merito alla vicenda mettendo in circolazione notizie false e mai verificate come pranzi e cene con noti e meno noti camorristi, incontri segreti, raccomandazioni, appalti.
Il primo interrogatorio di Tortora avvenne il 23 giugno 1983 e fu molto breve. Il giudice Di Pietro si rivolse con toni sgarbati chiedendogli se avesse mai avuto rapporti con Domenico Barbaro. Tortora guardò il suo avvocato Della Valle, il quale conservava le fotocopie delle lettere che il presentatore e il detenuto si erano spediti nel ’79. Barbaro infatti aveva inviato a Portobello dei centrini da tavola, perché venissero battuti all’asta durante la trasmissione, ma il pacco che li conteneva era andato perduto e la Rai aveva risarcito il proprietario con 800 mila lire.
I magistrati, fidandosi senza dubbi della versione di Pandico, che all’epoca condivideva la cella con Barbaro, erano convinti che quelle lettere nascondessero un messaggio in codice. Per i magistrati non si parlava di centrini ma di droga che Tortora avrebbe dovuto restituire alla camorra.
Il giudice chiese a Tortora se conoscesse una certa Nadia Marzano. Secondo il Barra, è nella sua abitazione che sarebbe avvenuta l’affiliazione di Tortora alla Nco, ma il presentatore negò e successivamente negò anche la donna, che in quel momento non si trovava neanche a Milano per problemi di famiglia. Si concluse cosi il primo interrogatorio a Enzo Tortora, e prima di mandarlo via il giudice Di Pietro gli rivolse una frase che fece rabbrividire tutti in quella stanza: “buona fortuna”. Il presentatore scriverà poi in una lettera a La Stampa: “ e’ una frase che accetto da un venditore di biglietti della lotteria di Merano e non certo da un giudice. La magistratura che io sappia amministra la giustizia e non la fortuna”.
Trascorsero alcune settimane durante le quali Domenico Barbaro confermò pubblicamente la versione di Tortora riguardo alla questione dei centrini. Mancava poco al termine dell’istruttoria formale e gli inquirenti avevano raccolto pochi indizi contro Tortora, ma poco prima della scadenza del termine apparve una testimone, Rosalba Castellini, che dichiarò al giudice Di Persia di aver visto il presentatore consegnare a due uomini sacchetti di plastica contenente droga. Il tutto, secondo la donna, sarebbe avvenuto il 5 novembre del ’79 in uno studio di Antenna 3 Lombardia. Ed è proprio alle sue parole che i giudici decisero di aggrapparsi per confermare le loro accus
In carcere mancava l’aria, la temperatura raggiungeva i 40 gradi, le condizioni igieniche erano pessime e i paparazzi erano sempre lì appostati pronti a fotografare la sua ora di libertà. Ma allo smarrimento e all’incredulità delle prime ore si sostituì una forte determinazione, anche se non mancavano momenti di sconforto e il pensiero era rivolto esclusivamente alla sua famiglia.
Nella cella 12 del reparto infermeria del carcere di Bergamo Tortora venne a conoscenza dei nuovi verbali e delle nuove rivelazioni.
Nel secondo interrogatorio del 29 settembre 1983 il giudice istruttore Giorgio Fontana rilesse quanto dichiarato da Pandico e chiese a Tortora se i numeri presenti sull’agendina di Giuseppe Puca, noto camorrista, fossero i suoi. Il presentatore chiese di poter vedere quei numeri, ma il giudice aveva dimenticato di portare con sé l’agendina. Passarono i mesi e Tortora trascorse, ripiegato su se stesso nella branda, il suo primo capodanno in carcere. Gli furono vicino i compagni di cella, gli unici in grado di comprendere realmente ciò che stava attraversando, sapevano bene che in carcere un secondo sembra un minuto, un minuto un’ora, un’ ora un giorno e un giorno un mese intero.
Questo calvario ebbe effetti distruggenti sul noto presentatore. Le sue condizioni di salute si aggravavano giorno dopo giorno, era dimagrito di 11 kg e soffriva di depressione psichica
Tortora alternava momenti di speranza a momenti di rassegnazione fino al 17 gennaio, giorno in cui il tribunale della libertà di Napoli, al quale i suoi legali avevano fatto ricorso, gli concesse gli arresti domiciliari. Erano trascorsi 7 mesi dal suo arresto. Nell’ordinanza il presidente Giacomo Coracciolo, considerava superficiali i contenuti delle motivazioni di arresto adottate dal giudice Fontana e disponeva che il detenuto potesse telefonare, incontrare gente e riprendere il suo lavoro.
Tortora, venuto a conoscenza della decisione del tribunale, pianse a singhiozzi come un bambino. Tre carabinieri lo accompagnarono nell’ appartamento dove poté abbracciare finalmente i suoi familiari, si fece fotografare con la figlia, ma la sua era l’immagine di un uomo stanco, dallo sguardo smarrito e affaticato, di un uomo ancora in attesa di giudizio.
Il terzo e ultimo interrogatorio avvenne il 9 marzo 1984 Tortora arrivò a Napoli in autoambulanza, steso su una barella con le manette ai polsi. A quest’ultimo colloquio entrò in scena un noto killer; che stava scontando l’ergastolo per duplice omicidio, il quale dichiarò di aver visto Tortora a cena con un uomo della camorra in un locale di Milano. Un altro camorrista, Gianni Melluso, dichiarò di aver consegnato a Tortora undici chili di cocaina. Alle affermazioni dei suoi due nuovi accusatori Tortora si alzò in piedi sdegnato chiedendo di porre fine a quella farsa.
Trascorsero i mesi e il 4 maggio del ’84 il leader radicale Marco Pannella chiamò il suo amico Enzo Tortora offrendogli la candidatura al Parlamento Europeo nelle liste del suo partito. Il presentatore stava vivendo un momento molto delicato in quanto era in attesa di un processo, il cui esito sembrava già scontato. Nonostante ciò accettò la proposta e venne eletto eurodeputato con 485.000 voti. Tortora impiegò i primi mesi del suo mandato parlamentare partecipando ai lavori della Commissione giuridica e dei diritti umani. Aveva dei progetti ben precisi come afferma lui stesso : “ a Strasburgo intendo condurre una battaglia di dignità civile per il cittadino e per il magistrato in Italia. E’ assurdo che nel nostro paese gli stanziamenti per la giustizia non superino lo 0,75 % della spesa pubblica. Ho visto detenuti che da 7, 8 mesi erano in carcere e non avevano ancora incontrato il giudice per l’interrogatorio. Forse a voi questo pare normale. E io vi dico che è un oltraggio così profondo per un uomo e così atroce da mettersi ai margini di una civiltà giuridica”
Il 4 febbraio 1985 iniziò a Napoli, contro gli esponenti della criminalità organizzata, il maxi- processo che durò 6 mesi. Intanto il presentatore continuò a svolgere la sua attività al Parlamento Europeo anche se per pochi mesi. A conclusione del processo, dopo una camera di Consiglio di soli 6 giorni per 243 imputati, il presidente della Corte, Sansone, iniziò a leggere la sentenza che comprendeva nomi, date, numeri, articoli; tra i condannati ci furono il cantante Califano, Vallanzasca, Pandico, Melluso. Tutti aspettavano di sapere quale sarebbe stato il destino di Enzo Tortora. La Corte lo condannò a 10 anni di carcere, 50.000.000 di lire di multa e ad un anno di libertà vigilata a pena scontata. Tortora aveva deciso di non essere presente alla lettura della sentenza, restò a Bruxelles partecipando a una riunione della commissione giuridica del Parlamento Europeo. Commentò così la notizia della sentenza: “quando mi dissero all’apparecchio 10 anni, sentii un gelo al cuore. Poi provai rabbia, sconforto, indignazione …. Quella notte tardai ad addormentarmi … e vidi quel che Franz Kafka racconta nelle ultime tre righe del “Il processo” : un uomo mi posava le mani sulla gola mentre un altro mi immergeva un coltello nel cuore”.
Da queste parole si può capire cosa provasse in quel momento un uomo che era stato condannato ingiustamente ad un destino crudele.
Come promesso nella compagna elettorale si dimise dal suo incarico di parlamentare europeo rinunciò all’immunità e restò agli arresti domiciliari. Tortora trascorse i primi mesi del ’86 in un clima di profonda apatia e monotonia.
Il processo d’appello iniziò il 20 maggio, dove fu demolito completamente il castello di accuse rivolte fino a quel momento. Pian piano i pentiti incominciarono a ritirare le accuse. Giuseppe Puca dichiarò che Enzo Tortora non era mai stato camorrista. Nella primavera di quel 1986 si assisté al tramonto di questo infame pentitismo; dopo Puca fu la volta di Alberto Sganzerla, poi di Mario Incarnato e di Salvatore Federico.
Dopo il periodo estivo, il processo riprese partendo proprio dalle arringhe degli avvocati difensori. I legali di Tortora erano molto preoccupati, ma Della Valle, Dell’Orca e Coppola parlarono per 10 ore ribadendo l’assoluta estraneità del loro assistito a qualsiasi fatto di camorra contestando tutte le accuse rivolte a Tortora e soprattutto quelle fornite da Melluso.
Le accuse furono scardinate grazie a un minuzioso lavoro svolto dal giudice Michele Morello e dai suoi collaboratori.
Ricostruirono tutto il processo, partirono dalla prima dichiarazione fino all’ultima e si resero conto che in quelle dichiarazioni c’era qualcosa di sospetto. Tortora nell’ udienza del 13 settembre concluse la sua difesa con parole molto toccanti: “ Signori della Corte io dovrei concludere dicendo: Ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi?Io vi dico: sono innocente, lo grido tra 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente e spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi!”
Alle ore 11:00 del 15 settembre 1986 il presidente Rocco e i giudici Morello e Ricci si ripresentarono in aula per leggere la sentenza, la quale assolse Enzo Tortora con formula piena dalle accuse di associazione a delinquere di stampo camorristico per non aver commesso il fatto e di spaccio di droga perché il fatto non sussiste. I legali del presentatore si abbracciarono commossi e pieni di gioia. Era finito un incubo che era durato 4 anni.
pastedGraphic_1.pdf
Il ritorno di Enzo Tortora e la malattia
Il 20 febbraio 1987 Enzo Tortora ritornò nelle case degli italiani con la prima puntata del nuovo Portobello. Nello studio di Fiera 2 di Milano il suo pubblico lo accolse con un lungo applauso sincero. Tortora iniziò la trasmissione con la celebre frase “dove eravamo rimasti?” e continuò “ potrei dire moltissime cose, e ne dirò poche: una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me in questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me: e io questo non lo dimenticherò mai. …. …. Un’altra cosa dovete consentire di aggiungere. Io sono qui, e lo so, per parlare a nome di chi parlare non può. E sono molti, e sono troppi …”
La decisione di Tortora di ritornare in tv si rivelò un ottima medicina. Il presentatore sembrava aver ritrovato una parte di se stesso, passava la maggior parte del suo tempo negli studi televisivi con i suoi colleghi che a volte lo sorpresero a piangere in silenzio. Ma la vita dopo l’assoluzione non fu per niente facile. Tortora doveva fare i conti con i ricordi che ritornavano alla mente specialmente prima di addormentarsi, non riusciva a dormire e a riposare, si alzava di soprassalto e sempre più stanco. Questa esperienza lo rese più debole e più forte allo stesso tempo. Nacque in lui la convinzione che l’uomo, per la sua esperienza, fosse l’animale più feroce che esistesse ma anche il più stupido.
Grazie al lavoro il noto presentatore si distraeva dai pensieri e dai ricordi che lo assillavano, ma il suo sguardo era cupo, molto spesso assente ed era spesso costretto a reggersi ad un bastone che ormai era diventato il suo compagno quotidiano a causa di problemi fisici. Tortora si sentiva cambiato, ciò che era accaduto lo aveva reso più vulnerabile più sensibile, si sentiva non più un uomo ma un reduce, un naufrago, praticamente non più lui.
Nel frattempo era in progetto la messa in onda di un nuovo programma “Giallo”, che non trattava solo l’intrigo e i gialli della finzione cinematografica o letteraria, ma anche casi misteriosi e inquietanti della realtà italiana e internazionale.
Infatti le inchieste curate dai collaboratori del presentatore si rivelavano veri e propri scoop giornalistici. Per la prima volta in tv si cominciò a parlare di argomenti delicati. Venne trasmessa l’intervista di una diciottenne, Paula Cooper, condannata a morte per aver ucciso un insegnante. In un’altra puntata Tortora approfondì le circostanze mai del tutto chiare della morte di Giovanni Paolo I, dibatté sulle stimmate di Padre Pio e in una puntata parlò per la prima volta del metodo di rilevazione dell’impronta genetica sperimentato in Inghilterra e sconosciuto in Italia.
Tortora non dimenticò mai l’ingiustizia subita; infatti presentò un lungo esposto al ministro della Giustizia Giuliano Vassalli e al procuratore generale della Cassazione Vittorio Sgroi, pregandoli di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di quei magistrati che si erano occupati del suo caso ma anche nei confronti dei titolari degli uffici giudiziari che non avevano vigilato e controllato l’intera inchiesta commettendo dei gravissimi errori. Si appellò inoltre alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo chiedendo la condanna dell’Italia per i giorni che lui aveva trascorso ingiustamente in carcere o ai domiciliari e un risarcimento di 100 miliardi di lire per i danni morali e professionali subiti. Nei mesi successivi le condizioni fisiche di Enzo Tortora peggiorarono; venne operato per un polipo alla vescica e ricoverato a causa di una doppia ernia del disco alla colonna vertebrale. Il suo stato di salute lo costrinse a passare la maggior parte della giornata a letto con dolori allucinanti sperando sempre in una giustizia che prima o poi sarebbe arrivata. Ma questa speranza diventò tutto d’un tratto un’ utopia quando apprese che il Parlamento italiano aveva votato la cosiddetta legge-truffa sulla responsabilità civile dei giudici, la quale consentiva al cittadino di chiedere il risarcimento soltanto allo Stato ( e quindi a spese di tutti i contribuenti) unicamente nei casi di colpa grave od omissione di giustizia. Tortora si auspicava che almeno il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, potesse ascoltarlo e gli inviò una lettera chiedendo inutilmente la non promulgazione della legge. La sua voce ancora una volta non fu ascoltata, la voce di un uomo che ormai doveva combattere non solo contro l’ingiustizia ma anche contro un male ancor più grande, un tumore al polmone sinistro.
“il destino vuole che le mie condizioni di salute siano divenute molto gravi proprio mentre si tradiscono Costituzione, referendum, giustizia e diritti …… lotterò fino all’ultimo respiro.”
Durante il periodo della malattia Tortora si informò assiduamente su ciò che accadeva in Italia, si consultava con i suoi legali circa le denunce a carico dei magistrati e dei giornalisti che avevano leso la sua immagine, cercò delle soluzioni che gli potessero dare un senso di riscatto e di giustizia. Morì troppo presto a soli 60 anni il 18 maggio alle 10:00 del 1988 a causa di un arresto cardiaco.
Tortora è stato in quegli anni il protagonista di una vera e propria tragedia che ha saputo fronteggiare con coraggio e determinazione sperando e credendo che prima o poi giustizia sarebbe stata fatta, ma non è stato così. Le cause intentate presso il tribunale civile di Roma e della Corte Europea dei diritti dell’uomo sono state sospese e nessuno ha realmente pagato per gli errori commessi.
Sono trascorsi quasi 30 anni dalla notte in cui Enzo Tortora fu arrestato e anche se il suo ricordo è sempre meno presente nella mente degli italiani, il suo cognome è diventato il simbolo della giustizia ingiusta, di una giustizia che non ha saputo difendere i propri figli ma li ha condannati a un destino crudele. Mi piace qui ricordarlo con le sue parole rivolte alla figlia Silvia:
“ ora che pago sulla carne e nel modo più feroce e ingiusto, ti posso assicurare che sono nato il 17 giugno. Hai un papà neonato. Esperienza rara”
“ il carcere corrompe anche i sogni. Ho sognato di far parte, comportandomi benissimo, di una bada di svaligiatori di appartamenti”
“ quello che non si sa è che una volta gettati in galera non si è più cittadini ma pietre, pietre senza suono, senza voce, che a poco a poco si ricoprono di muschio. Una coltre che ti copre con atroce indifferenza. E il mondo gira, indifferente a questa infamia.”
“ da tre mesi, sottoposto ad uno stress, a un angoscia che non riuscirò mai a descriverti, io marcisco in galera. Certo: come molti altri abitanti di questo pianeta della disperazione e del dolore che sono spesso, troppo spesso, dimenticati dagli errori di alcuni giudici e da una procedura a dir poco medievale”
“ ma certo qualcosa di irreparabile è accaduto dentro di me, non so se più a livello psicologico o fisico, o a tutte e due”
E ancora:
“ mi domando, cara Silvia, che cosa posso insegnarti dal carcere di Regina Coeli. Fra le mura della 16 bis, dove fa un caldo atroce. Siamo in sei disperati, e fuori si vede il cielo. Che posso insegnarti mi chiedo: perché è a te, devi saperlo, è a te che il mio pensiero più spesso vola”
Sono queste le parole strazianti di un padre, di un giornalista, di un presentatore nonché di un uomo che ha vissuto quegli anni nella disperazione, nello sconforto, nella delusione più totale, un uomo la cui più grande paura era l’ indifferenza. L’ indifferenza nei confronti della sua sorte e di quella di tanti altri cittadini sbattuti in carcere in attesa di essere giudicati in un processo.
Per questo ciò che bisogna fare è NON DIMENTICARE!!!
Le anime più forti sono quelle temperate dalla sofferenza
I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.
(filosofo, Khalil Gibran)
CAPITOLO III
La tutela delle vittime di malagiustizia: Associazione “Art. 643”
Dopo esser venuta a conoscenza, grazie al film “L’uomo sbagliato”, di una realtà crudele che conoscevo poco, decisi di approfondire il tema proposto dal film con una ricerca mirata grazie alla quale ho appreso di clamorosi errori commessi dalla giustizia nei confronti di tantissime persone che per anni hanno pagato un prezzo troppo alto prima di veder riconosciuta la loro innocenza e la loro estraneità ai reati per i quali erano stati accusati.
“L’uomo sbagliato” è Daniele Barillà, arrestato l’ 11 febbraio 1992 per un scambio di persona. I carabinieri del Ros arrestarono uno dei boss mentre trasportava un carico di 50 kili di cocaina, dietro di lui viaggiava, ignaro, Daniele Barillà, che guidava un auto identica a quello di un narcotrafficante: stessa Fiat Tipo color amaranto con 3 numeri di targa uguali. Barillà venne fermato e arrestato per concorso e complicità in traffico internazionale di sostanze stupefacenti e scontò da innocente sette anni e cinque mesi di carcere. E’ lui una delle tante vittime di errori giudiziari.
Ma chi si preoccupa di questa gente? Credevo nessuno, specialmente dopo aver letto la storia di Enzo Tortora.
Ritenevo che le vittime di questa giustizia ingiusta fossero lasciate sole al loro destino, che il più delle volte si tramuta in un incubo dal quale svegliarsi risulta essere difficile e faticoso.
Ma mi sbagliavo. Continuando la ricerca sugli errori commessi dalla giustizia sono venuta a conoscenza della esistenza a Bologna di un’Associazione Nazionale dal nome “Articolo 643”. Spinta da un grande interesse ho deciso di contattare il presidente, l’avvocato Gabriele Magno, che ho raggiunto personalmente nella sede dell’associazione in via San Gervasio n. 6 a Bologna.
L’incontro con l’avvocato è stato per me utile e importante in quanto mi ha chiarito molti aspetti di una cruda realtà che molto spesso è lasciata ai margini dell’interesse dell’opinione pubblica e solo pochi ne parlano.
Io ho deciso invece di parlane, di presentare una delle tante realtà nere che appartengono al nostro paese e di dar voce a quattro vittime della giustizia che vorrebbero far conoscere a più persone possibili le loro storie.
Da ben 11 anni l’associazione tutela le vittime di errori giudiziari, ingiusta detenzione e lungaggini processuali, grazie al lavoro svolto da professionisti, tra cui avvocati, docenti universitari, psicologi e giornalisti che hanno messo a disposizione la loro professionalità per le centinaia di persone che ogni anno subiscono errori giudiziari o ingiusta detenzione, diventando per loro un vero e proprio punto di riferimento.
Uno studio dell’Eurispes ha mostrato la gravità di tale problema. Infatti dal ’48 al ’99 sono state 4 milioni le persone che hanno subito il carcere ingiustamente e mai nessuna associazione prima del 2000 si era mai occupata di questo fenomeno.
L’associazione si fa promotrice di alcune proposte legislative importanti e una delle tante riguarda l’ingiusta detenzione. La richiesta di indennizzo ha un limite di due anni dopo la sentenza definitiva e questo è inconcepibile in quanto oltre i due anni lo Stato non paga; quindi sarebbe opportuno che venga eliminato il limite e ci sia la possibilità che ogni soggetto vittima di un’ ingiusta detenzione possa far richiesta di riparazione in ogni tempo. Anche perché ,come spiega l’avvocato Magno, molte persone dopo aver concluso la loro vicenda giudiziaria e sono stati riconosciuti innocenti dopo 3,4,7 anni vorrebbero solo ricostruire un presente e poi un futuro e i primi anni sono quelli in cui si cerca di recuperare ciò che hanno perso, vogliono dimenticare e non prendono subito in considerazione l’idea della riparazione. Una seconda proposta è quella di riabilitare l’immagine, l’onorabilità, il nome delle vittime di ingiusta detenzione ed errore giudiziario al fine di facilitare la loro reintegrazione nella società permettendo di riaffacciarsi al mondo lavorativo senza essere vittima di un pregiudizio.
Durante l’incontro l’avvocato mi parlò di cifre, di numeri, e dell’ imponente quantità di richieste di riparazione per ingiusta detenzione. Su circa 8000 richieste ne sono state risarcite 2000; sono circa 100 i casi di errori giudiziari in un anno.
Incredula ho preso coscienza che questi non sono solo numeri, ma che dietro si nascondono delle persone che a causa di omonimia, di scambio di persona o a causa di un semplice errore del tutto evitabile hanno passato un inferno e mi sono resa conto che ognuno di noi può essere protagonista di storie al limite della realtà. Per questo non bisogna sottovalutare il problema ma bisogna approfondirlo, parlarne e diffonderlo.
L’avvocato Magno mi ha portato a conoscenza dei tantissimi casi da lui seguiti offrendomi la possibilità di contattare quattro delle innumerevoli vittime della giustizia: Columbu Maria Antonia, Gentile Claudio, Spanò Francesco, Bonifacio Fabio. Ognuno di loro mi ha mostrato una grandissima disponibilità, sono stati molto gentili e con una gran voglia di raccontarmi ciò che avevano vissuto. Parlando con ciascuno di loro mi sono resa conto quanto devastante sia un’ esperienza del genere perché, anche a distanza di anni, non si riesce dimenticarla e a rimuoverla dalla mente.
Ho sottoposto loro delle domande al fine di trarre le emozioni provate in quel periodo e anche nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della vicenda giudiziaria.
3.2 Storie di vita
Storia di Columbu Maria Antonia
La signora Columbu ricorda bene la sua triste vicenda conclusasi nel 2007. Tutto cominciò quando degli agenti di polizia le comunicarono che era indagata perché sospettata di essere una terrorista. Il sospetto nei suoi confronti nasceva da alcune sue parole scritte in una home page, frutto di esternazioni personali in un periodo difficile della sua vita, parole che furono considerate pericolose. La signora Maria non ha mai fatto parte di associazioni politiche e si è sempre dedicata amorevolmente alla cura ed educazione dei suoi 4 figli. Ma per ciò che stava accadendo nel nostro paese, era molto critica nei confronti delle istituzioni che non volevano ascoltare le reazioni dei giovani e della gente che desiderava soltanto una qualità di vita migliore.
Mentre gli agenti perquisivano la sua casa, in cerca di denaro o documenti, la signora Maria continuava a ripetere che lei non c’entrava nulla, che non era una terrorista. Nessuno le credette. Perquisirono le stanzette dei figli e rovistarono anche tra i giocattoli. Maria Antonia cercava di rassicurare i suoi piccoli anche se in quel momento non aveva una spiegazione da dare a se stessa. Nell’arco di pochi anni è stata arrestata e messa ai domiciliari, rilasciata con l’obbligo di firma due volte al giorno, riarrestata e messa in carcere.
Dopo il secondo grado di giudizio che riconfermava la prima sentenza di colpevolezza, la signora Columbu aveva voglia solo di mollare, di non credere che tutto potesse risolversi. Era sicura che ricorrere in Cassazione non sarebbe servito a nulla. Per fortuna non fu così in quanto fu assolta dalle accuse a suo carico.
Maria Antonia cercava di far pesare il meno possibile questa orrenda situazione a tutta la sua famiglia, ma davanti ad un errore del genere, come riferisce lei stessa, è impossibile. A casa i suoi figli non potevano più incontrare amici, perché la mamma era ai domiciliari, e non poteva avere contatti con nessuno che non fosse della famiglia.
Non poteva più accompagnarli a scuola, non poteva più essere presente come prima nella loro vita e questo fa molto male ad una madre. A distanza di anni la Signora Columbu non ha mai scritto la parola fine e non sa se riuscirà mai a scriverla.
Storia di Bonifacio Fabio
La sera del 26 novembre 2002 Fabio stava tornando a casa da una festa di compleanno accompagnato in auto da un amico. Ad un certo punto si accorsero di un’auto abbandonata, con gli sportelli aperti e le luci accese. Fabio la riconobbe: era quella di un ragazzo che conosceva, A.P.
Si fermò ritenendo che fosse successo qualcosa; subito dopo si fermarono anche due ragazzi che chiesero cosa fosse successo. Mentre questi rimasero lì per controllare la macchina, Fabio andò subito dal padre di A.P. , che gli chiese di accompagnarlo dove si trovava l’auto.
Da questo momento iniziarono i problemi del signor Bonifacio. Il padre dell’amico, O.P., gli disse che la sera precedente vi era stato il furto dell’auto con richiesta di riscatto ai danni del figlio, che aveva fatto la denuncia ai carabinieri, e che da li a poco lo avrebbero chiamato per fargli delle domande sul ritrovamento della macchina.
Il giorno dopo Fabio dette ai carabinieri tutti i chiarimenti su quella sera e in successivi interrogatori confermò sempre la stessa versione. Tutto sembrava essere un iter normale. Dopo alcuni giorni il padre della vittima chiese a Fabio di metterlo in contatto con un tale R.R. che lo stesso Fabio conosceva. Solo dopo tante insistenze Fabio accettò di accompagnarlo, senza chiedergli il motivo, a casa di R.R. e egli rimase in macchina ad attenderlo.
Il 23 gennaio 2003, Fabio si recò in caserma convocato dai carabinieri, ai quali raccontò nuovamente cosa era accaduto la sera del ritrovamento dell’auto. Gli fu chiesto di spegnere il cellulare e lo condussero in una stanza, dove il maresciallo G.S gli comunicò, senza specificarne il motivo, che dovevano trattenerlo perché era in arresto. Dopo qualche giorno di attesa Fabio incontrò il G.I.P alla presenza del suo avvocato P.R. e in quell’occasione venne a conoscenza del reato di cui era accusato: concorso nella consumazione dell’estorsione, rivestendo il ruolo di intermediario tra l’autore R.R. e la vittima dell’estorsione A.P.
Il 20 maggio 2004, dopo diversi mesi di detenzione, iniziò il processo di I grado durante il quale sia la vittima sia i carabinieri diedero versioni contraddittorie fra loro. Nelle prime udienze la vittima e il padre avevano sempre affermato la colpevolezza di Fabio, nell’ultima udienza del processo di primo grado invece lo scagionarono totalmente da ogni accusa affermando che Fabio non aveva mai chiesto del denaro. Nonostante ciò il 18 novembre 2004 il giudice lo condannò a 5 anni di reclusione e a 600 euro di multa.
Dopo 279 giorni di reclusione in carcere e 724 di arresti domiciliari, il 27 ottobre 2005 si svolse l’Udienza di Appello presso la Corte di Lecce che assolse Fabio Bonifacio con formula piena per non aver commesso il fatto e giudicando incompetente il giudice di primo grado per non aver tenuto conto degli elementi emersi a suo favore durante le varie udienze. Risultò che Bonifacio assunse la veste di intermediario tra gli estorsori e la vittima agendo nell’esclusivo interesse di quest’ ultima per disinteressati motivi di solidarietà umana.
L’avvocato L. C. , che aveva assunto la sua difesa portò avanti la richiesta di risarcimento non solo per la detenzione patita, ma anche per la squalifica sociale e le ricadute morali. Ma la Corte d’Appello il 22 gennaio 2009 rigettò la richiesta affermando che con il suo comportamento il Bonifacio aveva dato causa all’arresto. Un anno dopo anche la Corte di Cassazione rigettò la richiesta di risarcimento adducendo le stesse motivazioni. Ciò che il Signor Bonifacio non comprende è che se la Corte di Appello di Lecce l’ha completamente assolto e affermato che la sua azione si basava su un profondo altruismo, come può il suo comportamento essere causa del suo arresto?
“ sto cercando di lottare con tutte le mie forze, anche se non mi è rimasta nessuna speranza, almeno per dare rilievo a quanto succede a gente come me, che sembra non avere voce, ma che non è solo un numero, ma prima di tutto un essere umano”
La storia di Spanò Francesco
Il 22 dicembre 2009 alle 04:30 bussarono al portone di casa del Signor Spanò. Alla porta c’era il fratello, ma non era solo. Aprì la porta e si ritrovò in casa 2 uomini incappucciati che gli puntarono la pistola e gli dissero di stare calmo perché non sarebbe successo nulla in quanto erano carabinieri.
Subito dopo entrarono in casa altri sei carabinieri e gli notificarono un mandato di arresto con immediato accompagnamento in carcere. Francesco incredulo di ciò che stava accadendo, continuava a ripetere che si trattava di un errore in quanto era cresciuto in un ambiente militare: il padre era carabiniere, lui sottoufficiale di marina ed ufficiale di polizia giudiziaria marittima, il fratello agente di polizia locale. Francesco chiese ripetutamente di quale reato fosse accusato e gli risposero che avrebbe dovuto chiedere alla D.D.A. di Reggio Calabria in quanto erano reati di stampo mafioso. Si presumeva che appartenesse ad una cosca pericolosa della zona.
Al momento della perquisizione i due figli di Spanò, di 8 e 2 anni, dormivano nella loro cameretta, ma il più grande, svegliato dai rumori, si alzò e vide un uomo incappucciato. Lo fissò senza dire nulla. Francesco si vestì incredulo e lasciò la sua casa: “mentre scendevo le scale mi girai per salutare ancora una volta mia moglie e miei figli , li vidi piangere e li lasciai in un’angoscia e sgomento più profondo. Li rassicurai che si trattava di un errore e che presto sarei tornato a casa” e venne portato dai carabinieri in caserma a Reggio Calabria.
Lo arrestarono nell’ambito dell’operazione “Maestro”. Il blitz del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri scattò all’alba di quella notte. In manette finirono 27 indagati. L’indagine ,che era condotta dalla Procura di Reggio Calabria, ricostruì tutti i movimenti ed equilibri mafiosi della Piana di Gioia Tauro. Oltre all’associazione a delinquere di stampo mafioso, gli inquirenti ipotizzarono anche l’associazione per delinquere finalizzata all’introduzione in Europa di ingenti quantitativi di merce contraffatta, con l’aggravante della trans nazionalità ed altri reati doganali. I carabinieri sequestrarono beni per cinquanta milioni di euro. L’indagine colpì gli affiliati alla cosca Molè.
Il 23 dicembre alle 09:00 ci fu l’incontro con i magistrati che gli confermarono la custodia cautelare in carcere. Sia Francesco che i suoi legali rimasero allibiti dal provvedimento. Trascorse Natale, Capodanno ed Epifania in una cella piccolissima: “ sono state le feste più brutte della mia vita, la mia famiglia sembrava tenesse un lutto in quanto non ero lì con loro a giocare con i miei figli, era usuale per me vestirmi da babbo natale per portare loro i regali la notte del 24. E’ stato un Natale nero all’insegna dell’angoscia, dello tristezza e dello sgomento”.
Ma Francesco con l’indagine Maestro non c’entrava nulla. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia affermò fin da subito che non aveva mai avuto alcun rapporto con individui ritenuti affiliati della cosca Molè.
Gli avvocato di Francesco il 5 gennaio depositarono un’ istanza di revoca della misura cautelare, il Gip ordinò l’immediata scarcerazione di Spanò che dopo 17 giorni tornò un uomo libero.
La storia di Gentile Claudio
Claudio Gentile era un dipendente della Provincia di Palermo. Quando iniziò il suo incubo, nel 1999, Claudio aveva 31 e da quattro anni lavorava come funzionario nei Servizi di Controllo Ambiente.
Il 24 giugno 1999 alle 05:00 di mattina gli uomini della Digos (polizia di stato della questura di Palermo) in borghese bussarono alla porta della casa del Signor Claudio, dove viveva con sua moglie e i suoi figli, di cui la più piccola di 16 giorni. Entrarono, perquisirono la casa da cima a fondo ma non trovarono nulla. Lo condussero in questura senza dirgli niente. Claudio lì venne a conoscenza delle accuse a suo carico: era accusato di corruzione, associazione a delinquere e truffa ai danni dell’amministrazione da cui dipendeva , dopo di che gli fecero firmare l’ordinanza di custodia cautelare. Iniziò così il suo calvario.
Claudio sperimentò tutte le misure cautelari. Venne portato in carcere e in isolamento per 3 giorni, poi in una cella comune con 5 detenuti, che stavano scontando una pena per rapina a mano armata e tentato omicidio, che lo ridussero in pessime condizione psico- fisiche. Restò 40 giorni in carcere, 60 giorni ai domiciliari con l’obbligo di firma. Dal 2006 al 2009 subì 4 anni di sospensione dal servizio.
In Appello il 15 luglio 2009 arrivò l’assoluzione per i reati di corruzione e di associazione a delinquere, non per il reato di truffa che fu dichiarato estinto. Il signor Claudio si trovò ad affrontare ulteriori problemi perché fu rinviato a giudizio dal pubblico ministero della procura della Corte dei Conti di Palermo, Adriana La Porta. La Sezione Giurisdizionale del Tribunale contabile lo condannò a versare alla Provincia 60mila euro, cifra che salì a 75mila. Claudio presentò ricorso alla sede giurisdizionale di appello della Corte dei Conti che rigettò il ricorso nel 2011 in quanto quest’ultimo non rientrava nel merito della condanna contabile di primo grado.
Per i magistrati contabili il comportamento di Claudio Gentile aveva causato il reato di truffa di cui era accusato. Nonostante l’assenza di elementi per dimostrare la sua responsabilità amministrativa e nonostante per i giudici d’appello mancasse un rapporto diretto di causalità tra la condotta contestata al signor Claudio e il danno erariale, per la Corte dei Conti l’assoluzione di Claudio dall’imputazione di corruzione,“ deve ritenersi irrilevante ai fini della contestazione della responsabilità amministrativa, atteso che, a prescindere dalla mancanza di prova affermata dalla Corte di Appello, dell’effettiva commissione di questo reato da parte del Gentile, non ci sono margini di dubbio circa il suo contributo, la cui condotta appare determinante per la realizzazione della truffa ai danni dell’amministrazione provinciale, e per la conseguente indebita liquidazione di corrispettivi a fronte di prestazioni lavorative non rese”
Claudio oltre ad essere stato ingiustamente privato della libertà personale è stato privato anche di quella economica in quanto scattò il pignoramento del suo stipendio come recupero della somma da versare allo Stato. Spiega Gentile: “ mi resta da un lato il ricorso in Cassazione e la revisione processuale sempre se vengano accolte”.
Non è facile convivere in una situazione del genere avendo una famiglia da portare avanti ma il Signor Claudio non ha perso fiducia nella giustizia, nella magistratura e trova la forza di non mollare e di reagire senza dimenticare le innumerevoli vittime che come lui sono state coinvolte in un gioco giudiziario che sembra non avere mai fine. E pensando proprio a loro dice “ la sofferenza si attenua dietro l’humor che non sono riusciti a togliermi.
3.3Le conseguenze di una giustizia ingiusta
Le storie che ho descritto sono molto diverse tra loro; le quattro vittime sono state accusate di reati differenti ma che comunque annientano in un attimo la dignità di uomo, di cittadino, l’onore, l’ immagine di una persona. Le domande che ho posto a Francesco, Claudio, Fabio e a Maria Antonia riguardano le emozioni provate al momento in cui si è venuti a conoscenza delle accuse a carico, le reazioni dei familiari, l’atteggiamento degli amici, dei conoscenti, dei colleghi di lavoro al momento delle accuse, la difficoltà di reinserirsi società. Ho cercato di capire chi in quei momenti difficili avesse dato loro sostegno e in che modo e in che cosa hanno avuto la forza per non mollare.
Le ultime due domande prendono in considerazione un aspetto molto importante che va sondato dinnanzi a persone che subiscono eventi così forti, scioccanti, sconvolgenti. Importante infatti è valutare ciò che in psicologia prende il nome di resilienza.
Quest’ultima è la capacità del soggetto di affrontare con positività gli eventi stressanti e traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita davanti alle difficoltà. Il soggetto è capace di ricostruire la dimensione persa attraverso una nuova lettura di sé, degli altri e del mondo individuando una nuova forza grazie alla quale superare gli ostacoli.
Infatti la capacità di tollerare o meno la sofferenza davanti a situazioni traumatiche è importantissima nei processi di adattamento dell’individuo.
La resilienza si costruisce nella persona in base ad alcuni fattori: la personalità, gli eventi della vita, le relazioni con persone premurose e solidali. Queste relazioni generano un clima di tranquillità, sicurezza e rassicurazione permettendo lo sviluppo del livello di resilienza, che quindi si evolve in maniera differente in ognuno di noi. Un altro fattore importante è l’ottimismo, quindi la tendenza ad intravedere aspetti positivi nelle cose, cercando sempre di trovare soluzioni alle difficoltà. Inoltre può essere appresa sviluppando l’autostima,che protegge dall’ansia e depressione, l’autoefficacia, la speranza e l’humor.
L’uomo resiliente non è infallibile, ma presenta una grande capacità al cambiamento, vivendolo ed estraendo gli aspetti positivi.
Non è semplice ricercare e individuare il livello di resilienza in un soggetto, ci vorrebbe una ricerca approfondita a riguardo. Ma ho cercato di far emergere e capire quale fosse “l’ aspetto positivo” ,in una situazione che di positivo non aveva assolutamente nulla. La vita di queste quattro persone stava cambiando, in negativo, e ho voluto sapere cosa e chi proprio in quei momenti critici era visto come un “risorsa” che permettesse di non mollare, di andare avanti, di fronteggiare il cambiamento nella maniera più idonea e se vogliamo azzardare più “positiva” possibile.
Leggendo le risposte alle domande riscontro elementi comuni a tutti e quattro i soggetti. Fabio, Francesco, Maria Antonia e Claudio affermano di aver avuto fiducia, sostegno e credibilità dalla propria famiglia. Maria Antonia pensando ai suoi figli che l’aspettavano fuori dal carcere trovava la forza di reagire alle difficoltà. Nel frattempo per mantenere sempre vivo il rapporto, anche durante la detenzione, Maria Antonia scriveva ai figli ogni giorno e con amore attendeva le loro risposte che arrivavano puntualmente e poteva vivere in questo modo un attimo di serenità. Francesco ha sempre ricevuto il supporto dalla sua famiglia ma soprattutto il padre è stato colui che gli ha dato la forza di vivere e di non arrendersi mai. Fabio ha avuto accanto a sé molte persone: la madre, il padre che cercava di non mostrare la sua sofferenze ma i segni di quel periodo erano ben visibili sul suo volto, il fratello anche se abitava distante, e la sorella che si interessava di tutte le questioni legali oltre gli zii, cugini e tanti amici.
Per Claudio la moglie e i suoi suoceri gli hanno dimostrato una profonda solidarietà. Un ruolo importantissimo è stato rivestito proprio dalla moglie che gli è stata sempre vicino , ha sempre creduto in lui e gli ha trasmesso in ogni momento fiducia e amore. Inoltre supporto importante è stata la fede in cui ha trovato coraggio e serenità.
E’ possibile subito notare che, per tutti e quattro, la famiglia risulta essere il fulcro importante della loro vita, specialmente nei periodi di sofferenza. Infatti nell’ottica sistemico relazionale la famiglia viene considerata come un sistema vivente aperto, in cui ogni membro è in stretta connessione con gli altri componenti e il cambiamento di uno di essi comporta il cambiamento di coloro che fanno parte della famiglia. Proprio come accade ai nostri quattro soggetti.
Di conseguenza ciascun componente non è considerato indipendente dalle relazioni familiari che vive e ogni sistema familiare entra in relazione con molti altri sistemi, cioè altre famiglie, istituzioni, servizi. La famiglia, vista in questa prospettiva, permette di capire e affrontare i problemi in un modo decisamente migliore e viene considerata un sistema aperto grazie al fatto che i suoi componenti comunicano e l’interazione diventa una componente essenziale tra coloro che vi appartengono. Ovviamente un avvenimento, soprattutto traumatico e imprevisto, mette a repentaglio molti aspetti dell’equilibrio familiare e la famiglia deve fronteggiare le conseguenze che ne conseguono e utilizzare tutte le risorse disponibili per far fronte ai cambiamenti cercando di ristabilire un nuovo equilibrio. Non sempre è semplice ristabilire tranquillità e serenità in una famiglia che è stata distrutta da errori evitabili e infondati. Ma Maria, Francesco, Claudio e Fabio si impegnano insieme alle loro famiglie affinché questo accada.
Vi è in comune una forte determinazione nel dimostrare la loro innocenza, la loro estraneità ai reati per i quali erano stati accusati, perché loro sono persone oneste.
Dalla lettura delle risposte emergono specialmente le emozioni provate in determinati momenti e anche qui sussistono elementi comuni.
E’opportuno soffermarsi sulle emozioni che sono importantissime nella vita umana e sono considerate come la componente soggettiva che accompagna la condotta dell’individuo.
Sono diverse le posizioni teoriche assunte dagli psicologi riguardo la natura, l’origine e la funzione delle emozioni. Fino agli anni Sessanta gli studi sull’emotività si sono organizzati attorno alla controversia tra la teoria di James e quella di Cannon.
James propose nel 1884 una “teoria periferica” , secondo la quale “non piangiamo perché siamo tristi, ma siamo tristi perché piangiamo”: l’evento emotigeno causerebbe cioè una serie di cambiamenti a livello viscerale e neurovegetativo, cambiamenti percepiti dall’individuo e interpretati come esperienza emotiva. James parte dunque dalla semplice percezione di un evento che porta al “sentirlo emotivamente”, e pone alla base di questo sentire emotivo l’attivazione fisiologica dell’organismo (arousal) senza la quale non sarebbe possibile neanche definire un’emozione in quanto tale. La posizione di James fu molto criticata, soprattutto da Cannon, che riteneva che i visceri fossero troppo poco sensibili e le loro reazioni troppo indifferenziate per poter essere considerati effettivamente la fonte principale delle emozioni.
La “teoria centrale” di James Cannon, pur rimanendo legato all’origine neurofisiologica delle emozioni, sosteneva che l’emozione ha origine nella regione talamica dell’encefalo ed è dunque di natura centrale. Successivamente, a partire dal contributo di Cannon, altri studiosi hanno ipotizzato che il circuito posto come base dell’attivazione e della regolazione dell’emozionalità umana comprende tutta la zona composta dal talamo, ipotalamo (che coordina il sistema nervoso autonomo e se stimolato produce risposte emotive “complete”) e amigdala (considerata come il computer dell’emozionalità:da una parte – circuito subcorticale – valuta le emozioni in maniera rapida, precognitiva, attuando se necessario risposte tempestive, mentre dall’altro – circuito corticale – ponendo in contatto queste informazioni “primitive” con le aree associative della corteccia svolge funzioni superiori di valutazione dell’evento emotigeno).
La posizione di J. Cannon, centrata sugli aspetti neurofisiologici dell’emotività, risulta incompleta in quanto esclude ogni aspetto prettamente psicologico. Il primo a proporre un modello che tenesse conto anche di questo fattore fu Schachter, con la sua teoria cognitivo-attivazionale. Egli associò alla imprescindibile attivazione fisiologica una componente di natura psicologica che spiegasse l’attivazione fisiologia sulla base di un evento emotigeno coerente. Schachter sostiene che entrambe le componenti siano condizioni importantissime per gli individui al fine di provare qualsiasi stato emotivo, e che essi debbano inoltre essere accompagnate da un secondo atto cognitivo (successivo alla percezione e al riconoscimento dello stato emotivo) che permetta di stabilire una connessione tra i due fattori portando ad “etichettare” in maniera appropriata l’emozione che si sperimenta. Schachter tentò di trovare conferma sperimentale alla sua teoria e alle ipotesi da essa derivate, e in molti casi ebbe risultati incoraggianti.
Negli anni ottanta sorsero le teorie dell’appraisal. Con il termine Appraisal cui si designa la valutazione cognitiva degli stimoli. In psicologia delle emozioni, alcuni studiosi sostengono che emozioni diverse sono caratterizzate da differenti sistemi valutativi.
L’ appraisal sarebbe dunque all’origine della risposta emozionale. Secondo gli studiosi dell’appraisal le emozioni non possono nascere senza una ragione e la loro origine è riscontrabile sempre in una qualche forma di valutazione cognitiva della situazione collegata all’evento emotigeno con tutti i suoi possibili legami con il benessere e le aspettative, gli scopi, i desideri del soggetto coinvolto. Quindi le emozioni dipendono dal modo con cui gli individui valutano ed interpretano gli stimoli del loro ambiente fisico e sociale.
Altri studiosi, rifacendosi agli studi di Darwin, hanno preferito vedere le emozioni come reazioni sviluppatesi per la sopravvivenza della specie umana (ad esempio la paura porterebbe a scappare davanti a un pericolo, il sorridere come reazione di gioia faciliterebbe il riconoscimento di persone non ostili…). Le emozioni, quanto meno quelle primarie, vengono dunque concepite all’interno di queste teorie psicoevoluzionistiche come qualcosa di unitario e innato nell’uomo. Esse quindi, così come le corrispettive espressioni facciali che le caratterizzano,sarebbero geneticamente determinate e automatiche nel loro insorgere.
Le emozioni sono state divise in primarie e secondarie. Le primarie sono otto: rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, attesa, disgusto e accettazione; secondo vari autori dalla combinazione dell’emozioni primarie derivano quelle secondarie: allegria, vergogna, ansia, rassegnazione, gelosia, speranza, perdono, offesa,nostalgia, rimorso.
Ma quali sono le emozioni provate da chi viene accusato di un reato non commesso? Da chi deve trovare delle prove riguardo la propria innocenza? Da chi deve fare i conti con carcere, arresti domiciliari e pregiudizi della gente?
Maria, Francesco, Claudio e Fabio nel lungo periodo che li ha visti protagonisti provarono emozioni diverse : dalla rabbia per l’ingiustizia che stavano subendo, alla tristezza, alla speranza ma non solo. Non mancano l’incredulità nel momento in cui vennero a conoscenza dei motivi dell’arresto e la paura che genera innumerevoli frustrazioni che minano il senso di sicurezza, generando impotenza e indignazione nei confronti di tutti coloro che dovrebbero assicurare la giustizia.
Ma la vita non è stata solo difficile durante la detenzione ma soprattutto quando, assolti sono ritornati alla loro vita di sempre.
Per Maria non è stato semplice reinserirsi. Lei stessa ha cercato l’isolamento durante tutto l’iter giudiziario durato 9 anni, provando molta sfiducia nei confronti delle persone e delle istituzioni: “ l’esperienza della detenzione è demolitiva anche nei confronti dell’aspetto lavorativo, riduce la voglia di fare qualcosa. Gli ostacoli che si incontrano diventano quasi insormontabili e se prima inserirsi nel mondo del lavoro era quasi una sfida da dover vincere, dopo diventa solo motivo di ansietà. E’ la volontà che si assopisce”.
Fabio nonostante avesse avuto accanto a sé molti amici ha dovuto subire il pregiudizio e la cattiveria della gente che l’ha giudicato ancor prima di conoscere la verità. Anche per lui il reinserimento nella società e nel mondo lavorativo non è stato affatto semplice, ha dovuto lottare per far rivalutare la sua immagine e per far ciò ha fatto pubblicare a proprie spese la sentenza di assoluzione su un giornale locale ma nonostante questo c’è ancora gente che lo ritiene colpevole. Claudio non ha riscontrato molta difficoltà nel reinserirsi sia a livello lavorativo che umano, i suoi colleghi di lavoro si sono comportati come sempre. Francesco vive in un paese di 4500 anime e alla notizia del suo arresto rimasero tutti increduli e sbalorditi, purtroppo le difficoltà si riscontrarono specialmente dal punto di vista lavorativo.
Dopo l’assoluzione oltre a problemi derivati da pregiudizio, mancanza di lavoro e reinserimento sociale, non bisogna dimenticare la violenza psicologica subita da queste persone durante quegli anni, la quale ha effetti devastanti anche nel momento in cui un periodo traumatico ha fine.
Dopo l’esperienza subita Francesco, Claudio, Fabio e Maria Antonia si sentono spesso ansiosi e turbati, in una ricerca continua di tranquillità e serenità. Tutti e quattro affermano che non riescono ad addormentarsi facilmente, che accade rare volte di dormire bene.
Questo dimostra che l’evento traumatico è difficilmente dimenticato dal soggetto che è costretto a vivere in una situazione di squilibrio emotivo in quanto la gioia, la felicità e la serenità, pian piano riacquistate, lascia il posto improvvisamente all’angoscia, ai ricordi e alle mille domande che affollano la mente con i tanti perché. Il passato è alle spalle e Fabio, Maria Antonia, Claudio, Francesco hanno cercato di riprendere le redini della loro vita con orgoglio e onore perché loro hanno vinto contro un grande mostro chiamato: MALAGIUSTIZIA.
Conclusioni
Errori giudiziari e ingiusta detenzione sono uno dei tanti mali della società che affliggono noi semplici cittadini. All’improvviso non esiste più nulla. Come nelle fiabe dove scompare la strega di turno nella realtà a scomparire non è il male, ma la dignità, il rispetto e i diritti delle persone.
Nei tre capitoli affronto argomenti diversi tra di loro ma che hanno un denominatore comune.
Il primo capitolo descrive dal punto di vista giuridico le norme principali in materia di riparazione degli errori giudiziari ed ingiusta detenzione. Si comprende facilmente come l’eccessivo abuso nell’applicazione delle misure cautelari contribuisca a ledere molti aspetti morali e non di una persona. Su questo problema bisogna riflettere. Si tratta di superficialità? Incompetenza? Errore volontario o involontario? E’ difficile rispondere ma una risposta bisogna darla, soprattutto a chi da innocente è destinato a vivere all’interno di un meccanismo giudiziario “malato” che lo obbliga a subire lungaggini processuali, arresti domiciliari e scontare pene senza aver commesso alcun reato.
Nel secondo capitolo è descritta oltre la storia anche la sofferenza di un uomo che era riuscito con le sue qualità a diventare un uomo di altri tempi e a conquistare il pubblico televisivo, il quale però non esitò a scagliarsi contro nel momento peggiore della sua vita per poi accoglierlo con grande clamore al suo ritorno. Un ritorno che non durò molto. Enzo Tortora è uno dei tanti casi da non dimenticare. La scelta di dedicare l’ultima pagina del capitolo alle sue parole, dette nei momenti di difficoltà , è per far trapelare agli occhi di chi legge tutta la sua sofferenza di uomo e di padre.
L’incontro con l’avvocato Gabriele Magno è stato per me fonte di riflessione in merito alla tematica in oggetto che non si esaurirà a conclusione del presente lavoro. Desidererei tanto che le mie non fossero solo parole scritte su una pagina di word per una tesi, vorrei che ciò che ho presentato arrivi al cuore. Con uno sguardo al di fuori del nostro mondo ricordiamo che Maria Antonia Columbu, Francesco Spanò, Gentile Claudio, Bonifacio Fabio e come loro tantissime persone , hanno dovuto pagare un prezzo troppo alto per ciò che non avevano commesso.
Non si può rimanere indifferenti dinnanzi a tanto dolore. Bisogna impegnarsi per dare voce a chi voce ne ha consumata fin troppa per urlare la propria innocenza.
L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo
( Sofocle)
Bibliografia
Elga Turco, L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, Giuffrè, 2007
Lucrezia Fiandaca, Il danno non patrimoniale. Percorsi giurisprudenziali, Giuffrè, 2009
Alan Buddeley, La memoria: come funziona e come usarla, Laterza, Bari, 1993
Vittorio Pezzuto, Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora, Sperling & Kupfer, 2008
Valentina Marzella, Il secolo d’Italia, 26/10/2011
Sitografia:
http://www.youtube.com/watch?v=GLyAuyGvoYk&feature=results_main&playnext=1&list=PLB2A1AF21D33A524E
http://www.art643.org/page.php?id_page=5&name=Rassegna%20Stampa
www.studiperlapace.it
www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1098
http://www.mentesana.it/la-salute-mentale-othermenu-12/140-la-resilienza.html
Ringraziamenti
Ringrazio l’avvocato Gabriele Magno, Columbu Maria Antonia, Gentile Claudio, Bonifacio Fabio e Spanò Francesco per la disponibilità, fiducia e gentilezza che hanno dimostrato nei miei confronti per la stesura del presente lavoro.